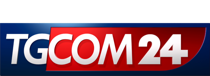Lo scorso 19 settembre, Gio Evan ha pubblicato il suo nuovo album dal titolo “L’eleganza del mango”. L’artista inoltre, il 9 novembre sarà in tour a Milano, con lo spettacolo teatrale dal titolo “L’affine del mondo”. Il nuovo disco di Gio Evan è un viaggio sonoro e narrativo che oltrepassa i confini della semplice discografia, intrecciando poesia e canzone in un unico flusso. Con “L’eleganza del mango” l’artista conferma la sua vocazione di “pensa-autore”, capace di unire scrittura, filosofia ed emozione in un linguaggio accessibile ma mai banale. Le tracce alternano ballate intime e momenti più ritmici e luminosi, componendo un percorso che restituisce immagini vivide ed emozioni immediate. Lo spettacolo, prodotto da Friends & Partners, racconta la storia di un mondo costruito dall’affinità e dalla connessione tra esseri umani. “L’affine del mondo” mescola poesia, fisica quantistica, musica e comicità per riflettere sull’importanza dell’ascolto e dell’armonia, proponendo un nuovo modo di concepire la vita e le relazioni. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Gio Evan: ecco cosa ci ha raccontato.
Intervista a Gio Evan
L’eleganza del mango” è un titolo curioso. Cosa rappresenta per te questa “eleganza”?
L’eleganza rappresenta un po’ il portamento e il carisma che che ha la pianta del mango. Stavo cercando delle qualità che potevano essere affini anche all’uomo e soprattutto necessarie all’umanità in questo periodo e il mango rispecchiava in tante gestualità e galatei vegetali queste caratteristiche essenziali.
Hai definito l’album un “romanzo musicale”: cosa volevi raccontare attraverso le canzoni?
Volevo raccontare l’archetipo della stanchezza più prossima alla prostrazione, seguita da un incontro di saggezza. Lì dove la più totale assenza di vitalità incontra invece una fonte di luce, rappresentata da questo ragazzo o ragazza è uguale. Ho voluto creare un percorso di illuminazione, un percorso che potesse ridare valore ed energia a una vita. Questo passaggio che può sembrare empatia o immedesimazione, in realtà altro non è che l’accettazione della totalità.
Da dove nasce il termine “romanzo musicale”?
In realtà nasce dalla mia ossessione di unire tutta l’arte narrativa che comunque mi ha iniziato perché ho quindici libri e quattro dischi, quindi, sono chiaramente uno scrittore prima. Ehm so che c’è un modo per unire l’orecchio all’occhio eh lo troverò lo scoprirò per ora riesco a unire ovviamente la parte nasata e il monologo la scrittura ehm la sfrutto come no? Nel vinile è una skip no in realtà eh termini di di oggi musicali e poi sussegue una canzone che insieme creano questo percorso di mh di concetto cioè la prima parte ehm il maestro dice al all’essere dice che ogni cosa è importante, illuminata e seguimi illumina. Una canzone che dice che anche nelle piccole sconfitte d’istruzione c’è una grande un gran repertorio di luce. Ecco quindi queste sono diciamo è la mia mhm la mia passione è quella di non sentirmi mai disunito. Quella di allacciare più più cose possibili. La questione qui sì sì è quella di unire unire più più cose possibile, renderle coerente anche poi devono essere trascritte in teatro il teatro come è stato difficile all’inizio unire la la poesia a teatro, poi la canzone cioè come fai e devi trovare un racconto che possa reggerle.
In brani come “Pachamama” e “Spirito guida” ritorna forte la spiritualità dei tuoi viaggi. Quanto c’è ancora oggi del Gio Evan che imparava dai maestri e dagli sciamani in Sudamerica?
Oggi come oggi, in realtà, c’è ancora di più quel Gio Evan, perché solo negli ultimi tempi sono riuscito ad allacciare relazioni e rapporti con i curanderi dell’Amazzonia, che frequento quasi ogni anno, se il tour me lo permette. Anzi, quando viaggiavo in precedenza ero molto più acerbo: non vivevo pienamente la magia e l’incanto di quei luoghi. Arrivavo a destinazione, mi fermavo al massimo un anno o un anno e mezzo, ma dentro di me c’era sempre quella frenesia del “adesso vado in Brasile, troverò qualcos’altro… poi in Amazzonia del Nord, poi in India…”. Adesso invece ho dei legami veri: uno dei miei migliori amici è un capo curandero dei Guaraní. Gli ho regalato un telefono con WhatsApp, ci sentiamo spesso, ed è bellissimo — lui mi manda foto di sé nudo con la cerbottana! Ora, più che mai, riesco a viaggiare in modo più coerente, più lento… e molto meglio.
Ti ha mai spaventato stare con loro?
No, ma è molto più spaventoso prendere la novantuno a Milano a mezzanotte. Cioè, noi scegliamo, in realtà, i timori di cui poi saremo composti. Io, che sono cresciuto in montagna, non mi spavento se ho un lupo sotto casa, perché so che linguaggio attua. So perché è lì. Sotto casa mia passano un sacco di lupi, davvero tantissimi. Devi, ovviamente, avere una certa formazione a riguardo — e io ce l’ho, più con quella parte selvatica. Quando vado dagli Amazzoni, vedo che le posture che loro assumono assomigliano molto di più alle mie. Io, per esempio, ho difficoltà a stare seduto al ristorante: la mia anatomia non corrisponde alla “buona educazione” occidentale. Quindi mi viene naturale, in realtà, essere più fiducioso nei loro confronti. E poi, se guardiamo la storia… di chi dovremmo avere paura? Dei popoli nativi americani, o di chi è andato a “trovarli”? Ovviamente, trovare è un modo di dire. Se dobbiamo cercare un cattivo, non sono mai stati loro — quelli che chiamavano “selvaggi”, proprio per parlar male di loro. Io sono sempre stato dalla parte del bene.
Nell’album ci sono collaborazioni con Julia Ortiz e Cisco. Come nascono queste affinità artistiche?
Julia Ortiz è stata la prima cantante che ho incontrato durante un viaggio a Buenos Aires. C’era un festival spirituale e, in quei trenta giorni di meditazione, lei suonava la chitarra con la band o con degli amici — non ricordo bene — e mi innamorai subito della sua voce. Poi mi accorsi che era famosissima, una vera star. Mi colpì moltissimo il suo modo di essere una super celebrità alla Manu Chao, senza che le pesasse l’essere famosa. In Sudamerica, poi, lei è praticamente un Dio. Siamo rimasti in contatto e siamo diventati molto, molto amici. Abbiamo fatto insieme diversi viaggi, e c’era una grande affinità. Poi, dato che volevo creare un disco molto libero con “L’eleganza del mango”, ho capito che in quella canzone aveva finalmente il suo posto, e l’ho fatta. Con Cisco, invece, la storia è diversa; io sono cresciuto manifestando per strada, ai tempi in cui le proteste erano tantissime. I Modena City Ramblers facevano musica di protesta, quella che cantavi quando avevi voglia di umanità. Ricordo la prima volta che vidi Cisco a una manifestazione per Carlo Giuliani a Genova. Ero ospite di Giuliano Giuliani, padre di Carlo e mio amico, e lì conobbi Cisco. Mi innamorai subito del suo essere un vero artista, autentico e potente. Così lo contattai subito.
Il nuovo tour teatrale, “L’affine del mondo”, unisce poesia, musica e fisica quantistica. Com’è nato questo progetto?
Nasce, in realtà, collezionando tutte le voglie che ho di trasmettere. Mi piace l’idea di unire. Da qui nasce sempre uno spettacolo teatrale. Dall’unione tra musica e pensiero, dal desiderio di avvicinare i concetti, di farli dialogare. Avevo qualcosa da dire che non riusciva a stare dentro una canzone — non poteva essere musicata. E non poteva nemmeno essere romanzata, perché ho già altre idee di romanzo. Così ho pensato: faccio uno spettacolo che parli di una riabilitazione del linguaggio. Lo spettacolo, infatti, crede — e invita — a far sì che, invece di voler cambiare il mondo, iniziamo a cambiare il modo: piccoli modi, gesti, pensieri. Perché è da lì che può nascere l’inizio di un mondo nuovo. Infatti, L’affine del mondo parla proprio di un nuovo inizio. Perché è attraverso l’affinità che riusciamo a instaurare, a installare e a considerare davvero l’altro. Nasce, quindi, da una voglia profonda di riunione.
C’è differenza nel rapporto con il pubblico tra un concerto e uno spettacolo teatrale?
Sì, sì, tantissimo! E lo facciamo apposta, proprio per diversificare le attenzioni. A Evanland, per esempio, c’è il sudore, la terra, la relazione fisica: è il luogo del bacio, della confidenza, della lacrima. Il teatro, invece, è un tempio. Se il club estivo può sembrare una rimpatriata, il teatro è una messa, un’eucaristia. Lì arriva il messaggio. A teatro mi impegno per far sì che siamo uniti da un pensiero. E quel pensiero avviene: è lì che ci sentiamo uniti, ed è da lì che nasce la ricerca delle altre persone. Chi ci segue non lo fa dicendo “mi piace la sua musica” o “mi piace il suo libro”: ci segue perché c’è un percorso comune, un’esperienza spirituale in tutto e per tutto. Le persone che mi incontrano non chiedono una foto: chiedono “sono stressato, che meditazione posso fare?”. Si è creato, ormai, un cerchio, una famiglia, che continua insieme questo percorso di crescita e consapevolezza.
“L’affine del mondo” parla di connessione e affinità tra esseri umani. Ti sembra che oggi, nell’epoca dei social, siamo ancora capaci di vera connessione?
Dipende da quale luogo stiamo valutando. Nei miei luoghi, nelle mie terre, sì, ce n’è tanta. Ovviamente, nelle grandi città è più messa a dura prova, perché oggi c’è una grande strumentazione di distrazione: siamo distratti da qualsiasi cosa. Nelle città troviamo grandi cartelloni, pubblicità ovunque… abbiamo il telefono, internet, e mille altre cose che mettono la nostra attenzione a dura prova. Io però credo che potremmo anche vivere un’epoca distratta, ma l’attenzione non morirà mai. Perché noi siamo nati per relazionarci, per ascoltarci, per prestarci attenzione. Sicuramente, stiamo attraversando un periodo di grande distrazione, ma torneremo ad essere attenti.
Hai pubblicato anche il romanzo “Le chiamava persone medicina”. In cosa differisce per te curare il mondo con le parole scritte rispetto alle canzoni?
Ma in realtà non c’è una vera differenza. Ci sono tanti modi di raccontare una storia, e tanti modi di riceverla. A volte abbiamo bisogno della musica, a volte della solitudine o di un romanzo; altre volte abbiamo bisogno del teatro, o magari di una pioggia. Dipende. La cosa importante, in realtà, è essere predisposti — predisposti a ricevere. Tutto qua.
Il processo creativo invece tra un libro e una canzone per te lo vivi in una certa maniera?
No, no! La canzone è un sussulto: ti esplode dentro e ti giri intorno per vedere se, dove ti trovi, c’è una chitarra. È un fremito. La canzone freme, nasce all’improvviso. Poi magari puoi costruirla con calma nel testo, ma la melodia, la voglia, sono un’esplosione. Il romanzo, invece, è tutt’altro: è essere capaci di vivere un autunno, di praticare un inverno interiore. Non ha nulla di esplosivo: è un’intimità profonda, a volte persino scomoda. Se lo attraversi in un periodo difficile, se non stai bene con te stesso, o hai ancora cose da chiarire con te o con altri, il romanzo diventa una prova. Perché la sua lentezza ti costringe a guardarti dentro, a vedere tante cose di te. E prima devi sistemarle tutte, poi puoi scrivere. A me capita anche con la casa: se è in disordine, se ho piatti da lavare o cose da mettere a posto, non riesco a lavorare. Devo prima pulire tutto — lo spazio, la mente — e solo dopo riesco a scrivere, perché è tutto in ordine. Così funziona anche con il romanzo: sono duecento, trecento pagine che richiedono una coerenza totale, dalla A alla Z, senza perdersi in nessun passaggio. E per riuscirci non puoi essere “sporco” dentro, altrimenti quel libro verrà letto senza passione.
Nei tuoi testi ricorrono spesso i temi della cura, della lentezza e dell’ascolto. È la tua forma di resistenza al rumore di oggi?
Sì, ma non è una forma di resistenza. Semplicemente pratico quello che penso sia più naturale per l’uomo. L’equilibrio sta proprio nella capacità di ascolto, nel trascendere tutte le velocità che propone il mondo. Tutto qua. In realtà, tutto diventa ascolto: se ti ascolti, ti accorgi che è inutile correre dietro alle velocità della società. Ascoltandoti, sai quando parlare e quando fare silenzio. Non è un atto di ribellione, il mio. Il mio è un atto di consapevolezza — mi piace tantissimo vivere fuori dalle distrazioni.
Dopo tanti anni di viaggio, successo e palchi pieni, cosa ti fa ancora “fermare ad ammirare”?
A me piace una cosa che ormai sembra quasi brutta da dire: mi piace la vita. Mi piacciono i panorami, i paesaggi, gli alberi, i boschi, i prati, i fiumi, i mari. Ho sempre viaggiato dannatamente lento. Ho visto pochissime terre in tre anni di Sud America: c’è chi ha viaggiato in moto e ha visto molto di più. Io no, perché sono lento. Mi piace conoscere le persone che vivono nei bar, nelle piccole strade, nelle piazzette. Sono lento, e mi piace questo. Mi piace assaporare, non ingoiare. Mastico tantissimo, fino a quando il paesaggio si è sciolto dentro la mia bocca. Solo allora, lo butto giù.
Se dovessi spiegare con una frase cosa significa per te “l’eleganza del mango”, cosa diresti?
Attenzione e cura verso qualsiasi forma di vita.