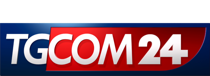Caterina Filograno porta in scena una parte della sua vita nello spettacolo teatrale “Anche in casa si possono provare emozioni forti”, una produzione di Sardegna Teatro, Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale e Teatri di Bari. L’autrice e attrice, formata alla Scuola Luca Ronconi, ha scelto un’opera matriarcale che mostra, attraverso cinque donne, cinque generazioni diverse. Scopriamo insieme cosa ci ha rivelato sul significato profondo dell’opera e sui progetti futuri.
Intervista alla autrice e attrice Caterina Filograno
Dopo il successo di Monopoli e Bari, “Anche in casa si possono provare emozioni forti” arriva il 12 e il 13 dicembre 2025 alla Triennale di Milano. Scene e costumi dell’opera sono curati da Giuseppe Di Morabito mentre le coreografie sono di Ester Guntin.
Di cosa parla e come è nata l’ispirazione di questo spettacolo?
“Questa è un’opera che racconta la famiglia in un modo un po’ particolare: attraverso la psicoanalisi, il mondo di Jung e di Freud. Lo facciamo con un allestimento molto onirico, la scena e i costumi sono dello stilista Giuseppe Di Morabito, che è un mio caro amico da più di dieci anni, nonché uno stilista molto bravo e affermato.
È una storia di matriarcato e mi sono ispirata alla mia famiglia, che è una famiglia di donne che si sono sempre emancipate attraverso la cultura. Sono donne forti che, come dico provocatoriamente, hanno utilizzato gli uomini solo per la procreazione e giochiamo un po’ col romanzare la realtà.
La prima immagine che ha generato questo spettacolo è per me quella di mia nonna, seduta nella rotonda della nostra villa sul mare in Puglia, che è la location che ispira tutto. Qui contempla, di pomeriggio, i pappagalli che stanno sui pini marittimi. Ormai noi, da pugliesi, siamo stati completamente colonizzati dalle cocorite, abbiamo un clima praticamente tropicale.
È un’immagine un po’ paradossale ma anche piena di contemporaneità, che porta con sé la memoria di chi riesce ancora, forse, a stare in una situazione semplice di contemplazione senza un cellulare in mano. Senza fare nulla se non guardare, anche per una o due ore. È uno spettacolo un po’ nato per cristallizzare la sua memoria, perché comunque la morte si avvicina, lei ora ha 94 anni”.
Di quali emozioni si parla nella sua opera e quale emozione spera arrivi di più al pubblico?
“Sono un’autrice che gioca molto con l’ironia, con il politicamente scorretto, provoco. Non lo faccio per il femminismo ma per essere fedele alla descrizione della mia storia familiare. Poi è chiaro che ne faccio un lavoro femminista, ma sono un po’ contraria alle propagande, ci tenevo a precisarlo.
A livello emotivo sicuramente mi piacerebbe che il pubblico si ritrovasse in qualcosa che non conosce, come in un déjà vu di un ricordo. Io mi apro molto in questo spettacolo, apro il mio cuore, la mia anima e mi denudo proprio. Lo spettacolo inizia con una grande immersione nella forma, abbiamo fatto un lavoro con una coreografa spagnola molto brava, i costumi Di Morabito che sono molto barocchi.
È come se la forma la abbandonassimo per lasciarci guardare nella nudità della nostra anima e quindi nel cercare di lasciare al pubblico una nostalgia tenera e una inquietudine, forse, di un passato che non conosce ma potrebbe ricordare”.
Come ha detto prima si tratta di uno spettacolo autobiografico, come mai hai scelto questo titolo?
“Oggi viviamo in una società in cui cerchiamo sempre di più di provare, dato che sono a Milano, l’experience. È tutto un’experience, è tutto un famolo strano, perché sembra (per ricollegarmi a mia nonna che contempla i pappagalli) che non riusciamo più ad apprezzare le cose semplici. Siamo un po’ quasi anestetizzati anche dal mondo dei social, per provare qualcosa diventa sempre più difficile.
Il mio titolo è casa intesa come famiglia, quindi in primis le emozioni forti le proviamo in famiglia, che è il luogo da cui scappiamo, torniamo, da cui è così difficile emanciparci. E poi, devo dire, era anche un omaggio al mondo di Lina Wertmüller, al mondo dei romanzi, mi piaceva l’idea di un titolo lungo. I miei produttori mi hanno detto che il titolo era lunghissimo ma gli ho spiegato che sarebbe piaciuto e infatti è la cosa che mi chiedono sempre come mai ho scelto questo titolo”.
Oltre ad aver curato il testo e la regia di questo spettacolo, lei recita anche. Ci racconta il suo ruolo?
“Io interpreto me stessa, nel senso che è la mia storia. Io sono Caterina, ‘Me, myself, and I’ e quindi in una versione teatrale, in questo mio doppio sul palco. Scherzando, sono a metà tra Lady Gaga, Isabella Rossellini e Dorothy del Mago di Oz, cioè sono nel mio delirio di onnipotenza in cui guardo la mia fiaba ad occhi aperti.
Il mio sogno di fare un grande spettacolo in cui i miei burattini sono i personaggi della mia famiglia, e mia sorella interviene per dire che non la pensa come me e non è d’accordo. Si svolge tutto attraverso dei sogni che vivo, di cui sono la narratrice, e poi finisco anche per essere quasi divorata dalla mia stessa narrazione, in un grande gioco di scatole cinesi”.
Sul palco siete cinque donne che rappresentano tre diverse generazioni. Ha utilizzato qualche stereotipo, archetipo, oppure la storia vostra familiare?
“In realtà non sono tre le generazioni, ma sono cinque. La piccola Rebecca, mia sorella che ha 25 anni, io ne ho 35, e come ben sappiamo siamo due generazioni diverse. Poi c’è mia zia che ha più o meno sui 45 anni. La madre invece una decina d’anni in più, verso i 55, e poi c’è la meravigliosa Maria Grazia Sughi che è una vera matriarca del teatro che ha 85 anni.
A me piaceva l’idea di far dialogare delle generazioni così diverse, e sicuramente il ruolo degli archetipi è molto importante tipo Laurie Young, e quindi la nonna interpreta proprio il ruolo della grande madre. Poi c’è quello della figlia, della primogenita, della secondogenita, la sorella, come anche il ruolo della zia che è un po’ la figlia sacrificata del Sud che alla fine non si sposa per far compagnia alla nonna.
La nonna è un po’ la custode della villa, del giardino. Giuseppe Di Morabito ha pensato per lei un look da apicultrice ottocentesca reinventata, perché è proprio lei la giardiniera, che custodisce e che controlla”.
Quali sono le principali differenze emotive che ha riscontrato in queste cinque diverse generazioni di donne?
“È una bellissima domanda perché le differenze emotive si trovano soprattutto nella piccola Rebecca, che è un po’ anche l’attrice a cui ha dato il compito più difficile. Lei irrompe portando la realtà, fa un monologo in cui si chiede che cosa vuol dire essere normale, perché la definisco normale. Porta anche una certa dose di violenza e di voglia di rompere il sistema, è quella della famiglia che è più per la rottura.
È anche un personaggio che porta a qualcosa di profondamente politico, perché io ho voluto dare alla più giovane di tutti un ruolo difficile e di rottura. Secondo me i giovani, questa nuovissima generazione post covid, ha voglia di cambiare il sistema, rivedere i rapporti, rivedere il mondo.
È una generazione molto matura anche sulla salute mentale, su tanti temi, e che ha tanto da insegnare. Io sono un po’ a metà, sono per certi versi come mia sorella, ma per altri sono affascinata dal matriarcato, da una sorta di ancien regime di cui faccio parte, e sono più vittima anche degli stereotipi.
E mia nonna da matriarca è comunque una matriarca figlia del patriarcato, perché come dico sempre, oggi non potrebbe mai esistere un matriarcato puro, perché non possiamo cancellare millenni di cultura patriarcale. Le donne sono poi le prime a perpetrarlo. Infatti nel mio spettacolo racconto questo paradosso, cioè lo spettacolo si apre con mia nonna che si chiede quando mi sposerò, avrò dei figli, perché comunque per quanto possa essere fighissima alla fine la nonna del Sud quello vuole. E questi sono poi i paradossi”.
Cosa rappresenta per lei il matriarcato? Ho letto un’intervista che ha detto che non voleva mostrare soltanto il lato positivo di una donna, ma anche che sono un po’ cattive.
“Lo faccio in generale nei miei lavori, ho già fatto un lavoro in cui avevo tutte le protagoniste donne, e secondo me c’è una deriva culturale molto American style di buonismo e pensiero manicheo. Il mondo si divide in buoni e cattivi e adesso va di moda che le donne sono buone. Un po’ perché ci fa comodo, perché appunto dopo il Me Too cancelliamo tutti i millenni di soprusi e quindi facciamo le serie Netflix in cui le donne sono eroine salvatrici.
Ovviamente la realtà non è questa, anche perché secondo me il modo migliore per dare dignità alla donna è descriverla per chiaroscuri, nel bene e nel male, come anch’essa portatrice di crudeltà, di cattiveria. Il personaggio di mia nonna è un personaggio che ho voluto raccontare e dipingere proprio perché è così complesso.
È la complessità che interessa qualcuno che guarda perché altrimenti se semplifichiamo il pensiero non ci facciamo più domande. Per questo le mie protagoniste sono anche delle anti-eroine o comunque sono personaggi ambivalenti con grandi paradossi e contraddizioni interiori.
E poi aggiungo una postilla, ne parlavo ieri con la mia terapeuta, siamo noi donne che proteggiamo la cultura patriarcale. I più grandi sgambetti purtroppo li ho avuti da donne, quindi non possiamo non parlarne. Ormai siamo nel 2025 e dobbiamo assumerci anche noi donne delle responsabilità”.
Dopo questo spettacolo che progetti futuri ha?
“Ne ho troppi. Da alcuni anni sto lavorando al romanzo di questo spettacolo, perché questo spettacolo nasce come romanzo e ormai alla terza bozza di editing. La mia editor verrà a Milano e quindi capiremo ora come riprendere le fila di tutto. È un progetto molto lungo e complesso e verrà alla Triennale anche la mia art director Beatrice Papa che lavora nel mondo della moda ma si sta occupando del treatment del mio film perché vorremmo farne un film e per la location l’idea è la Puglia.
E poi io in parallelo lavoro in teatro, sto lavorando a un progetto su Ilona Staller con un artista portoghese. È un progetto più internazionale perché mi interessava proprio lavorare sul concetto di libertà, di corpo politico. Insomma di quanto può essere politico un corpo femminile”.